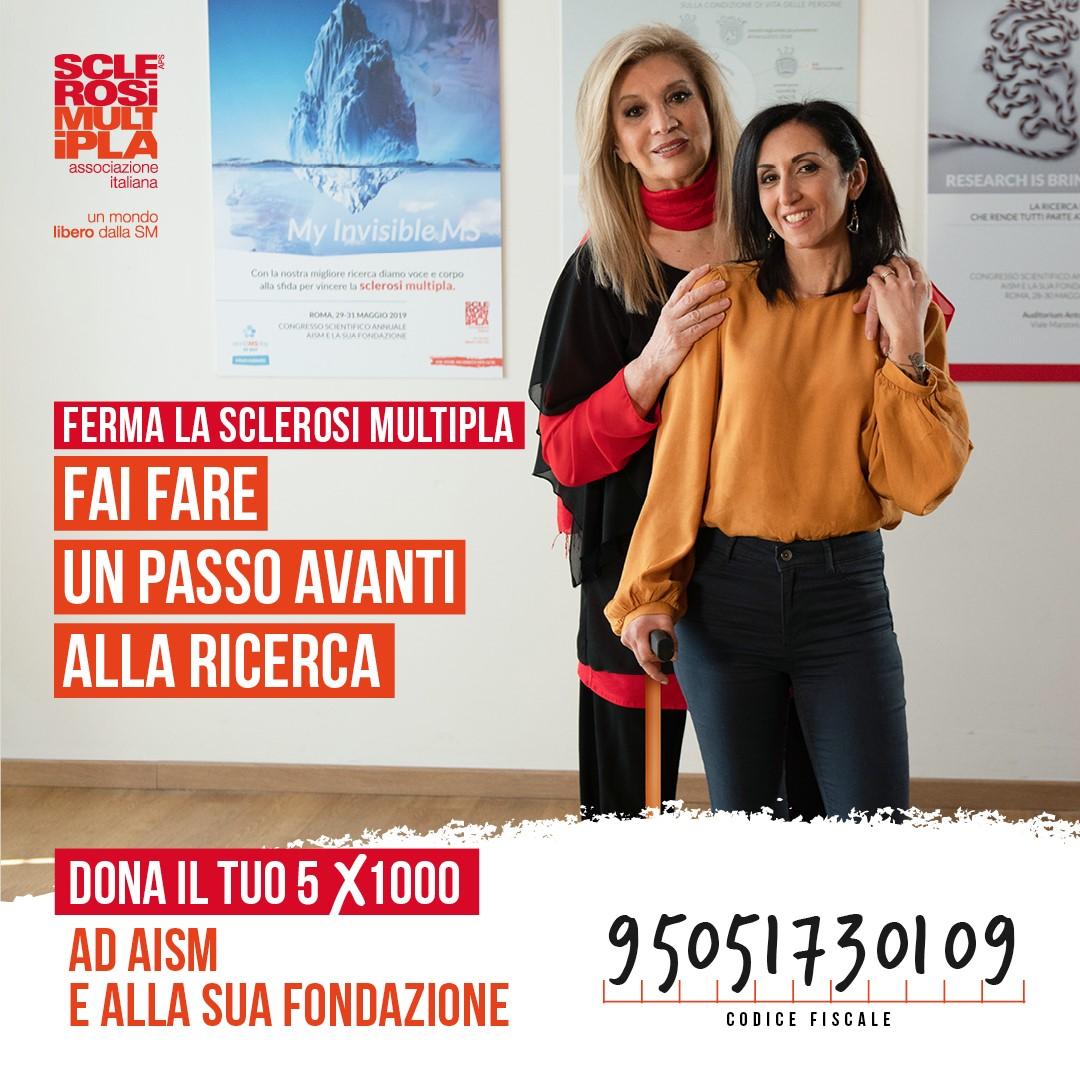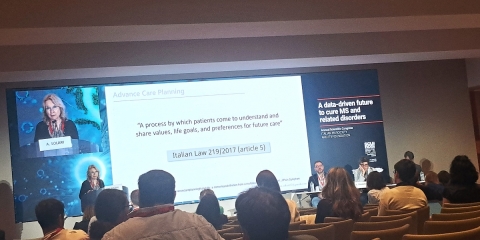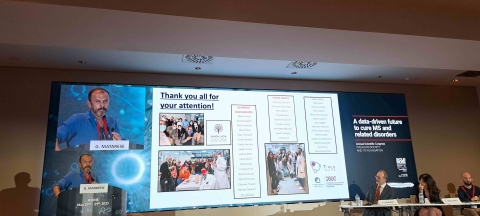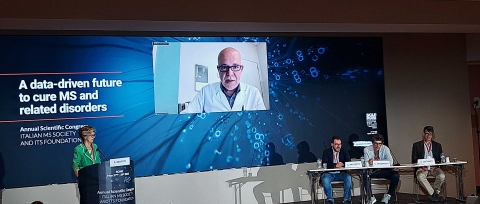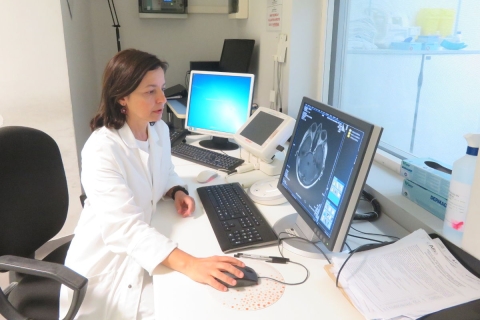Nella foto: la Prof.ssa Alice Laroni insieme al Prof. Mario Alberto Battaglia, Presidente FISM, riceve il Premio Rita Levi Montalcini nel 2016
Il microbiota, cioè l'insieme dei microorganismi che convivono con noi nel nostro organismo, contribuisce a regolare le risposte del sistema immunitario.
Essendo la sclerosi multipla una malattia a base autoimmune, in cui l’azione del sistema di difesa si rivolge in maniera anomala contro il nostro organismo stesso, molte ricerche oggi sono dedicate a indagare il ruolo del microbiota nello sviluppo e nella progressione della malattia.
In questo contesto si inserisce anche un nuovo studio, finanziato da AISM con la sua Fondazione FISM e pubblicato su Genes & Immunology, che aiuta a comprendere uno dei possibili meccanismi con cui il microbiota contribuisce a regolare l’azione di alcune cellule del sistema immunitario, le natural killer (NK). Una scoperta che potrebbe aiutare, in futuro, a sviluppare nuovi biomarcatori per la sclerosi multipla e ad aprire la strada a nuove strategie terapeutiche complementari.
La ricerca è stata guidata dalla professoressa Alice Laroni del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e scienze Materno-Infantili (DINOGMI) dell’Università di Genova e dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, vincitrice del Premio Rita Levi Montalcini nel 2016, e prende spunto dai risultati di un altro loro studio sostenuto da FISM: “Circa una decina di anni fa abbiamo dimostrato che un tipo di cellule natural killer, uno dei componenti del sistema immunitario, è capace di tenere sotto controllo i linfociti T, la cui funzione è alterata nelle persone con sclerosi multipla”. L’ipotesi di Laroni e colleghi - poi confermata da altri ricercatori - era che nelle persone con sclerosi multipla le cellule NK non funzionassero a dovere, e che questa disfunzione a sua volta contribuisse a sregolare anche la funzione dei linfociti T, di fatto producendo un’anomala reazione del sistema immunitario. “Abbiamo quindi cercato di capire meglio perché le cellule NK non funzionano bene: cosa modifica il loro comportamento?”.
Lo sguardo del team di Laroni - che comprende anche i professori Antonio Uccelli dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e Michele Piana dell’Università di Genova - si è dunque concentrato sul microbiota. “Il microbiota interagisce con il sistema immunitario attraverso la produzione di metaboliti che si trovano nell’intestino e nel sangue periferico - prosegue la ricercatrice - e tra questi di particolare interesse è un acido grasso a catena corta, il butirrato”.
Nel nuovo studio, gli scienziati hanno cercato di capire se il butirrato potesse essere in grado di influenzare la funzione delle cellule NK, spiega Federico Carlini dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, co-primo autore dello studio, insieme a Margherita Squillario dello stesso IRCCS: “Sapevamo che il butirrato può influenzare l’espressione genica di alcune cellule, modulando il modo in cui i geni sono impacchettati, ovvero la struttura della cromatina, volevamo sapere se può fare lo stesso anche per le cellule NK, e cercare di capire quali sono eventualmente i geni influenzati”.
Gli esperimenti condotti dai ricercatori hanno confermato che effettivamente questo metabolita prodotto dal microbiota altera la struttura della cromatina delle cellule NK (in gergo: agisce come un regolatore epigenetico). Le analisi di bioinformatica, condotte da Margherita Squillario, hanno confermato che alcune zone del DNA di queste cellule si modificano in seguito all’azione del butirrato, rendendosi più o meno disponibili per la produzione di proteine, come spiega. “Sono zone interessanti del DNA, perché colpiscono geni con funzioni importanti per il sistema immunitario”.
Quando osservato conferma l’ipotesi di partenza, ovvero che il microbiota, attraverso il butirrato, può influenzare l’attività delle cellule NK. “Abbiamo visto che questa sostanza può influenzare l’espressione genica di queste cellule. Quando usata per stimolare le cellule NK, le rende più capaci di uccidere i linfociti T attivati: di fatto ne potenzia l’attività regolatoria, un’attività cruciale e che sappiamo essere disfunzionale nella sclerosi multipla”, spiega Laroni.
Lo studio va ad aggiungersi a quelle ricerche che suggeriscono un potenziale ruolo “protettivo” del butirrato e dei microrganismi che lo producono, ma serviranno nuove ricerche per comprendere meglio le relazioni tra microbiota, sistema immunitario e sclerosi multipla. “Abbiamo già avviato uno studio presso l’Ospedale San Martino di Genova dedicato ad analizzare i metaboliti del microbiota nel plasma di alcune persone con sclerosi multipla e per analizzare più a fondo le cellule NK di questi pazienti - aggiunge Laroni - l’idea è quella di capire in che modo queste cellule possano essere influenzate dal microbiota”. Nel tentativo, in futuro, di poter sviluppare terapie complementari a base di pre e probiotici che possano aiutare a correggere disfunzioni immunitarie nelle persone con SM, ma non solo, conclude Laroni: “Grazie a studi come questo, in base alla funzione delle cellule NK e ai livelli di metaboliti come il butirrato, potremmo stratificare i pazienti e sviluppare dei biomarcatori prognostici, facili da ottenere e utili per predire l’evoluzione della malattia”.
Referenza
Titolo: Butyrate enhances CD56bright NK cell-driven killing of activated T cells and modulates NK cell chromatin accessibility
Autori: Federico Carlini, Margherita Squillario, Valentina Casella, Matteo Capaia, Valeria Lusi, Davide Bagnara, Monica Colombo, Serena Palmeri, Federico Ivaldi, Fabrizio Loiacono, Antonio Uccelli, Michele Piana & Alice Laroni
Rivista: Genes & Immunity
Doi: https://doi.org/10.1038/s41435-025-00338-2